Per un regionalismo differenziato e costituzionale, di Giorgio Armillei
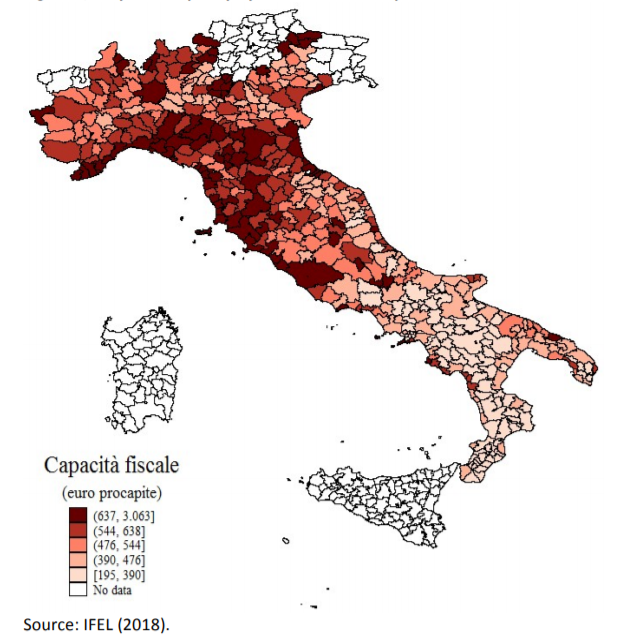
Tra le tante cose serie finite nel tritacarne della
propaganda nazionalpopulista spicca in questi giorni la questione del
regionalismo differenziato. Come sappiamo, a partire dalla riforma del 2001 la nostra Costituzione prevede che, al termine
di una procedura complessa che investe Assemblee regionali, Governi regionali, Sindaci,
Governo nazionale e Parlamento nazionale, anche solo alcune tre le Regioni
possano occuparsi di politiche pubbliche che al momento rientrano tra quelle di
competenza dello stato centrale. Nuove politiche pubbliche per le Regioni vuol
dire naturalmente anche nuove risorse finanziarie per coprire le nuove spese. Risorse
in mano per ora allo stato centrale che le prende dalle tasche dei cittadini
attraverso il prelievo fiscale e le usa per fornire beni e servizi, pagare gli stipendi
dei dipendenti pubblici, pagare i debiti. Politiche e risorse finanziarie
dunque. Ed è qui che la propaganda populista si scatena.
Andiamo per ordine. Primo punto: nuove competenze significa
risorse aggiuntive per le Regioni. Da dove vengono queste risorse? Da quello
che si capisce la proposta prevede che in una prima fase lo stato faccia i suoi
conti, stabilisca quanto spende ad oggi per quelle competenze e trasferisca
alle Regioni un importo pari a quanto dicono quei conti. Si chiama spesa storica:
una specie di istantanea finanziaria che blocca la spesa ad oggi e la
trasferisce così com’è alle singole Regioni, in base alla spesa
territorializzata.
Secondo punto: si tratta di un sistema che congela per
sempre la spesa storica? No. La proposta prevede che questo sistema si applichi
sino al momento in cui entreranno in vigore i criteri di fabbisogno standard.
Cosa è il fabbisogno standard? È quanto si stima che una pubblica
amministrazione debba spendere per fornire quel servizio, non solo in relazione
alle sue caratteristiche strutturali (una specie di costo aziendale di
produzione) ma anche alle caratteristiche del territorio di riferimento di quel
servizio, caratteristiche sociali, economiche, geografiche. Il che significa,
come si intuisce, che il fabbisogno standard non coincide con la spesa storica:
può essere superiore – se la spesa storica ha sottoinvestito in quel settore –
o inferiore – se la spesa storica ha sovrainvestito. In altri termini, nell’applicazione
del criterio del fabbisogno standard per stabilire le somme da trasferire dallo
stato alle Regioni qualcuno ci perde e qualcuno ci guadagna. Per questo i
fabbisogni standard non piacciono granché a molte amministrazioni pubbliche.
Bene o male (i criteri di calcolo sono ovviamente discutibili) il fabbisogno
standard se accoppiato alla capacità fiscale standard (quanto un territorio può
generare in termini di gettito) è impietoso: ci obbliga a chiederci come mai
qualcuno a parità di capacità fiscale spende troppo e qualcun’altro troppo poco
rispetto al fabbisogno.
Della sgrammaticata resistenza delle pubbliche
amministrazioni all’applicazione dei fabbisogni standard (o dei loro
equivalenti funzionali) è tanto consapevole la proposta di regionalismo
differenziato del governo Lega-M5s che prudentemente si premunisce da probabili
rinvii prevedendo una clausola di salvaguardia. Dopo i primi anni di
applicazione del principio della spesa storica, se non si viene a capo
dell’applicazione dei fabbisogni standard, si passa a un altro criterio. Lo stato
trasferirà alla Regioni oggetto del regime di regionalismo differenziato non
più la spesa storica ma una somma calcolata in relazione al valore medio pro
capite nazionale della spesa statale, cioè a quanto lo stato spende pro capite
in quella materia. E qui delle due l’una, considerando che le Regioni di cui
stiamo parlando beneficiano di una spesa media pro capite in linea di massima
inferiore alla media nazionale: l’applicazione della clausola di salvaguardia
comporta o un aumento globale della spesa statale (la differenza tra spesa
media pro capite nazionale e spesa media pro capite delle Regioni ad autonomia
differenziata) o una redistribuzione di risorse dalle Regioni in prevalenza
meridionali che hanno una spesa media pro capite superiore alla media nazionale
a quelle ad autonomia differenziata.
È su questo punto che il Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio ha alzato la paletta
rossa: la clausola di salvaguardia cozza contro il principio costituzionale di
perequazione territoriale, contro il principio di trasferimento a invarianza
finanziaria e contro il principio di efficientamento della spesa pubblica.
Insomma un pasticcio incostituzionale.
Qui, con tutta evidenza, tocchiamo un punto esplosivo della
proposta. In sostanza l’autonomia differenziata per Lombardia, Veneto e Emilia
Romagna (almeno al momento) con questa clausola di salvaguardia verrà pagata
dal bilancio dello stato centrale con un aumento di spesa oppure dalle altre
Regioni con una corrispondente riduzione di trasferimenti necessaria a
finanziare l’applicazione della clausola di salvaguardia. In entrambi i casi
una soluzione insostenibile. Vuoi per ragioni di stabilità finanziaria: una
riforma degli assetti istituzionali che si risolve in una maggiore spesa per il
bilancio del settore pubblico allargato cozza con i principi costituzionali
relativi agli equilibri di bilancio, nonché con gli equilibri di finanza
pubblica rilevanti per le politiche dell’Unione. Vuoi per ragioni di
redistribuzione territoriale delle risorse: l’applicazione del principio di
perequazione previsto dalla costituzione non può risolversi in un colpo di mano
legato alla fotografia di una fase storica ma deve rispondere a criteri
razionali e coerenti di perequazione interna tra i territori del paese.
Mettendo per ora da parte due cruciali questioni - quella
relativa all’autonomia impositiva: le Regioni ad autonomia differenziata si
finanzino tassando i loro cittadini a fronte di una compensazione del prelievo
fiscale statale, cioè a pressione fiscale invariata piuttosto che a invarianza
di spesa, come scrive Sabino Cassese. E quella degli oneri del debito: chi
continua a pagare il debito contratto per realizzare, ad esempio, le
infrastrutture che vengono trasferite alle Regioni – la propaganda populista ha
avuto facile gioco a scatenarsi, complice il clima interno del governo e della
sua maggioranza. Da un lato si strilla allo scippo contro le Regioni povere da
parte di quelle ricche, dall’altro e simmetricamente si urla contro la spesa
pubblica pagata dai cittadini del Nord vessati da un fisco predatorio. Facendo
finta di non sapere tre indiscutibili verità.
La prima riguarda la storia del regionalismo italiano e il
rendimento dei governi regionali. Come Luca Ricolfi notava quasi dieci anni fa
in un suo studio sugli effetti perversi della redistribuzione territoriale
della finanza pubblica italiana, se da un lato non potrà non esserci uno
spostamento di risorse dai bilanci delle Regione a bassa performance, sia sul
piano dell’efficienza che su quello dell’efficacia, a quelli delle Regioni
sottofinanziate, dall’altro è anche vero che ci sono Regioni del Nord che
ricevono troppe risorse e Regioni del Sud che ne ricevono troppo poche.
La seconda riguarda un tratto comune delle politiche per lo
sviluppo locale degli ultimi decenni, sia quelle realizzate nelle aree del nord
che quelle realizzate nelle aree del centrosud. Non si tratta in questo caso di
quanto dare e a chi, si tratta di smettere di continuare e spendere risorse da
bilanci pubblici, dello stato, delle Regioni, dei Comuni, per politiche il cui
rendimento è spesso prossimo allo zero e che per di più generano rendite
consolidate per gli apparati che le gestiscono. Contratti di programma,
contratti d’area, aree di crisi complessa e così via: una prova di grande
fantasia nell’ingegneria istituzionale per politiche che l’analisi
controfattuale ha mostrato essere quasi totalmente inutili.
La terza riguarda la cornice istituzionale di tutta
l’operazione. Si può certamente procedere al regionalismo così come disegnato
dalla Costituzione, e quindi anche differenziando Regione da Regione, ma –
questo è il punto – lo si può fare con una sommatoria di accordi bilaterali tra
stato e singola Regione, al di fuori di un quadro di riferimento precostituito,
definito con il concorso di tutti i governi regionali? Con quali criteri lo
stato può dire no a un’intesa con una Regione e sì a quella con un’altra
Regione?
Meglio dunque fermare tutto e tornare alla casella di
partenza? Cioè a politiche top-down gestite dallo stato centrale? Ovviamente
no. Il processo per il regionalismo differenziato deve andare avanti ma dentro
una cornice di finanza pubblica da ripensare. Occorre in altri termini
sdoppiare la partita in corso e creare due binari paralleli.
Un binario per l’assetto istituzionale, nel quale confermare
i trasferimenti di competenze legislative dopo un robusto e analitico passaggio
parlamentare alla luce del principio per cui non si tratta di moltiplicare
dinamiche ministeriali sui territori quanto di ridurre e razionalizzare l’azione
dei pubblici poteri. Fa parte di questo primo binario un profilo al momento
seriamente trascurato, quello del ruolo delle città e delle aree metropolitane.
Trasferire competenze dello stato centrale alle Regioni significa soltanto
aumentare le capacità estrattive degli apparati regionali e allargare
opportunità per comportamenti predatori, senza distinzione geografica. Mettere
al centro le città – come dimostra il caso di Milano – vuol dire assecondare un
allineamento virtuoso tra sistemi urbani, modelli di governo e globalizzazione.
Abbiamo bisogno di più regole per i processi globali non di assessori regionali
più potenti.
Un binario per la finanza pubblica, nel quale riprendere il
tema dell’autonomia impositiva – non c’è autonomia legislativa e politica senza
autonomia impositiva, no representation without taxation – considerare il
profilo degli oneri del debito pubblico e dare certezze al quadro dei
fabbisogni standard. Solo con questi tre pilastri si potrà seriamente mettere
mano ad un sistema di finanza pubblica per un regionalismo differenziato
efficiente e agganciato ai principi costituzionali di buon andamento,
sostenibilità finanziaria e perequazione.
Il nazionalpopulismo ha fatto la sua parte e come al solito
ha ignorato le compatibilità. Ora tocca ai liberali, tutt’altro che obsoleti.

Commenti (0)